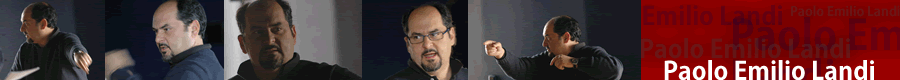
|
Etiopia: Carestia 2003
Addis Abeba, Awassa - aprile 2003 |
 |
 Come? Ancora? Quando leggi che in Etiopia 11 milioni e mezzo di contadini
rischiano di morire di fame, la prima reazione è di stupore e di
indignazione. Sì, ancora e peggio di prima. Quanti sono 11 milioni
e mezzo? Bisogna fermarsi un momento per ricordare che dietro quel numero
ci sono persone, c’è un mondo di affetti, di pensieri semplici
e profondi, di relazioni, di bisogni. Ecco che quella cifra diventa una
folla, l’ennesimo titolo di giornale diventa una tragedia umanitaria
e personale.
Come? Ancora? Quando leggi che in Etiopia 11 milioni e mezzo di contadini
rischiano di morire di fame, la prima reazione è di stupore e di
indignazione. Sì, ancora e peggio di prima. Quanti sono 11 milioni
e mezzo? Bisogna fermarsi un momento per ricordare che dietro quel numero
ci sono persone, c’è un mondo di affetti, di pensieri semplici
e profondi, di relazioni, di bisogni. Ecco che quella cifra diventa una
folla, l’ennesimo titolo di giornale diventa una tragedia umanitaria
e personale.
Ecco i dati: nell’anno 2002-2003 è tornata l’emergenza
siccità in Etiopia, l’unico paese africano a non aver conosciuto
il colonialismo (se si eccettua la breve occupazione italiana), una terra
grande quanto Francia e Germania insieme, costituita per lo più
da altopiani. Il governo, con l’aiuto del Programma per l’Alimentazione
Mondiale è in grado di prevedere con sufficiente precisione l’andamento
dell’agricoltura in base alla intensità e alla frequenza
delle precipitazioni atmosferiche. Ed ecco che sin da novembre scatta
l’allarme. Fino al prossimo raccolto, a luglio, c’è
necessità di nutrire 11 milioni e mezzo di persone. Solo nel mese
di aprile c’è sono stati distribuite 137.530 tonnellate di
cereali, anche se la quantità pro capite mensile è stata
ridotta a 12,5 kg.
Le cause della ennesima carestia sono molteplici e non tutte naturali.
Non è vero che in Etiopia non piova, anzi. Ma quando piove l’acqua
non resta nel suolo, scivola via portando con sè sementi e terreno.
Mancano le strutture per la conservazione dell’acqua. Il terreno
degli altipiani non è più o meno fertile degli altri. I
mezzi di coltura non sono adeguati. I contadini usano ancora l‘aratro
trainato da buoi e non possono andare a fondo, coltivano sempre e solo
lo strato superficiale del terreno. L’ecosistema del territorio
nazionale è cambiato negli ultimi 150 anni. Le guerre hanno deforestato
gran parte della nazione (prima c’era la foresta tropicale), per
la malsana abitudine di affumicare i nemici bruciando tutto intorno. Poi
l’aumento della popolazione ha creato la necessità sempre
maggiore di legno da ardere. Infine nell’800 è stato importato
l’eucalipto dall’Australia, una pianta che cresce velocemente,
fa ombra, ma non permette a niente di crescergli vicino. In due parole,
quella che potrebbe essere una regione fertile e produttiva ora è
un semideserto che non riesce a nutrire i suoi abitanti.
Ci sono poi i fattori macroeconomici: il prezzo del caffè (il prodotto
di maggior esportazione) è crollato del 70%, lo stato spende ancora
il 12,6 % del suo budget in armamenti, nonostante la guerra con l’Eritrea
sia finita nel 2000 (e questo fa ritenere che possa ricominciare), il
debito estero, è stato ridotto ma continua a strangolare la fragile
economia del paese.
E poi c’è l’AIDS. Il 3% della popolazione è
affetto da HIV. L’impatto sull’economia è rilevante.
Le famiglie vendono i propri beni per comprare le medicine, gli adulti
abbandonano i campi e i bambini spesso non vanno a scuola per poter badare
a loro.
Senza le strutture economiche e le infrastrutture tecniche, la carestia
non è l’eccezione, è la regola.
Con questi dati nella testa guardo il panorama
che scorre dietro il finestrino mentre percorro i 250 km da Addis Abeba
ad Awassa, nel sud del paese: un deserto popolato di acacie, grandi cumuli
creati dalle termiti, capanne, e contadini che spingono l’aratro.
Mi accompagna Feyessa Kayemo, il responsabile per lo sviluppo e gli aiuti
umanitari della Chiesa Protestante Mekane Yesus (letteralmente:il luogo
dove sta Dio), una denominazione nata dalle missioni luterane del nord
Europa. Fondata ufficialmente nel 1959 con circa 20.000 fedeli, ora ne
conta più di 4 milioni. Feyessa ha 50 anni, la sua etnia è
Oromo (una delle due che combatterono e vinsero contro il regime comunista
di Mengistu nel 1991). Si considera fortunato. La chiesa l’ha mandato
a studiate negli Stati Uniti. Lui, figlio di contadini, gestisce oggi
un budget di 10 milioni di dollari all’anno.
Mi accompagna nella zona in cui è nato. Scansando asini, capre,
buoi e venditori di chat (una pianta che masticata produce gli stessi
effetti dell’anfetamina, ma è legale) arriviamo in un grande
campo di calcio. La folla si è già raccolta. Cinque seimila
persone. Da una parte le donne con i bambini, sedute. I bambini hanno
la pancia gonfia e le donne sembrano tutte della stessa età. Dall’altra
parte del piazzale, in piedi, gli uomini. C’è silenzio. Un
silenzio assurdo, carico di attesa, ma anche indolente. Non tutti riceveranno
il sacco grano. Eppure sono lì. Come è noto, le emozioni
del giornalista non fanno notizia. Non parlerò di me, ma dell’operatore
che mi accompagna, un romano di grande esperienza nei reportages (insieme
abbiamo filmato i cadaveri dei ruandesi, nel 1996). Imbracciata la camera
ha iniziato a carrellare davanti alla fila delle donne e dei bambini.
Poi si è fermato. Gli occhi inondati di lacrime. Non ce la faceva
a continuare.
Come ci sembrano irreali quelle facce, quando occhi grandi ci spiano dalle
pagine dei giornali o dal repertorio dei TG. Eppure è realtà.
Quando ne senti l’odore, quando è davanti a te, sei impreparato
ad affrontarla. Feyessa non smette di ripetere che quella gente era a
scuola con lui, che lui è stato fortunato, che non capisce perché
… cosa aveva fatto, lui, per meritare di salvarsi? Che cosa abbiamo
fatto noi? - mi chiedo.
La distribuzione comincia: prima il cibo speciale per i bambini, un composto
altamente nutritivo; poi i sacchi di grano. Arrivano dagli Stati Uniti.
Dalle chiese protestanti? – chiedo - No, da quella cattolica. Ma
come? Feyessa spiega che la distribuzione degli aiuti umanitari è
uno dei campi in cui le tre chiese cristiane (protestanti, cattolica e
ortodossa, quest’ultima la maggioritaria) lavorano congiuntamente.
Tutti gli aiuti sono messi in comune e poi ognuno distribuisce secondo
le zone in cui ha uomini e mezzi. Così capita che i protestanti
distribuiscano riso mandato dai cattolici o gli ortodossi portino il grano
mandato dalle chiese europee, tramite Action of Churches Together (ACT).
Va de sé che la distribuzione non ha nulla a che vedere con l’appartenenza
confessionale o religiosa. La distribuzione non dura a lungo. La folla
ritorna nelle capanne di paglia e fango.
Ma Feyessa non è convinto di avermi
mostrato la cosa più importante: gli aiuti umanitari non bastano.
Non possiamo continuare a spendere il 12,6 % del PIL in armamenti e a
ricevere il 10% in aiuti, ogni anno. Bisogna mettere la gente in grado
di provvedere a sé stessa.
Mi spedisce a nord, nel Tigray, al confine con l’Eritrea, nei pressi
di Adua, dove i nostri furono sconfitti nel 1896 da Menelik II ( la data
di quella battaglia è festa nazionale).
Solomon Gidey, il capo progetto mi mostra un campo ben arato con i pomidoro
e i ranci ( pomodori e arance si chiamano così in questa zona).
Una fila di banani e di alberi di papaia incornicia questo rigoglioso
giardino. Tutto merito di una vecchia pompa Lombardini, Made in Italy,
che tira su l’acqua dal fiume e irriga tutta la zona. Costo: 3 mila
euro. Venticinque famiglie vivono su questo terreno. La pompa ha avuto
un impatto considerevole sull’economia della zona. Prima l’acqua
doveva essere trasportata a mano. Per questo le chiese europee hanno accettato
di pensare più in grande: con solo 100.000 dollari raccolti da
ACT, hanno deviato un fiume, costruito una canalizzazione e reso coltivabili
25 ettari, dando sicurezza economica a 400 famiglie. Il progetto è
semplice. Dall’altopiano scende un fiume che dopo pochi chilometri
si inabissa nelle viscere della terra. La piccola diga consente di deviare
l’acqua del fiume e di canalizzarla per 2 chilometri. Lo vedi? Non
possiamo far piovere ma la siccità si può combattere, mi
dice Solomon Gidey.
Pubblicato su Diario.
L'inchiesta televisiva e' andata in onda su Raidue- Protestantesimo.
Per richiedere il DVD:
